Servizi
Di seguito vengono riportati i servizi che possiamo offrirvi.
Per qualsiasi richiesta o informazione non esitate a contattarci
Nuove costruzioni da progetto, chiavi in mano
Progettazione e Realizzazione di richieste personalizzate, pensiamo noi a tutto. Per maggiorni informazioni contattaci.
Ristrutturazioni
Opere di restauro e risanamento conservativo per aumentare la sicurezza degli edifici intervenendo sul rinforzo, sull'isolamento termico e acustico.
Adeguamento antisismico
Opere di consolidamento e risanamento per aumentare la sicurezza degli edifici e rispettare le norme antisismiche vigenti.
Perchè Sceglierci!
Progettiamo, costruiamo e ristrutturiamo nell'ottica di ottenere un risparmio energetico. Per questo utilizzando materiali innovativi e tecnologie all'avanguardia fornendo soluzioni che soddisfano altissimi standard a qualità.


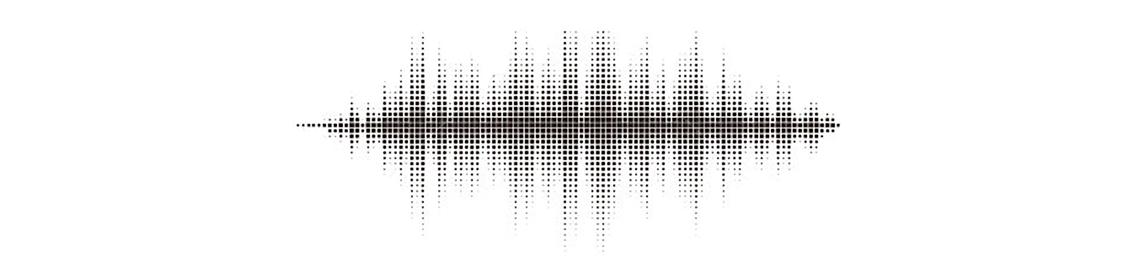
BIOEDILIZIA
I principi della bioedilizia possono essere applicati a tutti i tipi di edifici, indipendentemente dalle loro destinazioni d’uso.
Si possono quindi realizzare case in bioedilizia, asili, scuole, ospedali, centri ricreativi, ecc. Essa è molto indicata soprattutto per gli edifici ad alta frequentazione di persone e dove la permanenza degli individui è molto prolungata.
Per quanto riguarda i prezzi delle case in bioedilizia è possibile rilevare rispetto alle case tradizionali una maggiorazione dei costi di produzione compreso tra il 10 e il 15%, costi che possono, però, essere ammortizzati in breve tempo grazie al risparmio energetico garantito da questi edifici.
Gli elementi che caratterizzano la bioedilizia sono:
I materiali bioedili devono essere valutati secondo i seguenti criteri:
Oggigiorno l’attenzione dell’architettura per la bioedilizia sta crescendo sempre più. In particolare le case e, più in generale, gli edifici residenziali, sono le costruzioni più soggette a questa applicazione (ciò è in parte dovuto ad una maggiore attenzione da parte dei diretti interessati ovvero i proprietari delle case). La bioedilizia è infine molto applicata anche nei più moderni edifici dedicati all’infanzia, come gli asili e le scuole.
Oggi l'obiettivo della bioedilizia è la realizzazione di case ecologiche che rispettino, secondo una visione olistica dell'architettura, sia il benessere psicologico dell'individuo che i criteri architettonici e fisico-tecnici, al fine di ottenere l’ottimizzazione dei rapporti tra la struttura, gli utenti e l’ambiente circostante.
CASE A RISPARMIO ENERGETICO
Vengono considerate case a risparmio energetico quelle abitazioni che, grazie agli accorgimenti tecnici e tecnologici, limitano al massimo le dispersioni e gli sprechi energetici.
Ciò si ottiene grazie ad un involucro edilizio isolante e ad impianti di riscaldamento/condizionamento ad alta efficienza. Nella progettazione delle case a risparmio energetico, i tecnici devono tenere conto soprattutto della zona climatica nella quale rientra l’area di intervento. Un edificio a risparmio energetico completamente autonomo dal punto di vista energetico viene definito casa passiva.
Ciò si ottiene grazie ad un involucro edilizio isolante e ad impianti di riscaldamento/condizionamento ad alta efficienza. Nella progettazione delle case a risparmio energetico, i tecnici devono tenere conto soprattutto della zona climatica nella quale rientra l’area di intervento. Un edificio a risparmio energetico completamente autonomo dal punto di vista energetico viene definito casa passiva.
L’involucro delle case a risparmio energetico
Si chiama involucro abitativo il perimetro verticale ed orizzontale che separa l’abitazione dall’ambiente circostante.
Esso è formato da tamponature esterne, solaio di calpestio e copertura, che si suddividono in superfici opache (pareti, tetto, solaio) e superfici trasparenti (finestre, lucernai, ecc). Una casa a risparmio energetico, per essere definita tale, deve avere un involucro ben isolato che le possa garantire un comfort ambientale sia nel periodo estivo che in quello invernale. Con un buon isolamento termico si possono ottenere case ad alto risparmio energetico.
L’isolamento delle superfici opache si può ottenere con materiali edili isolanti come le plastiche cellulari come il poliuretano, il polietilene, o ancora meglio con pannelli in fibra naturale come il legno, la lana di roccia, il sughero, ecc. Questi strati generalmente non hanno caratteristiche strutturali, perciò vengono inglobati tra gli altri strati per essere protetti dagli urti e dagli agenti atmosferici.
La capacità isolante varia dal tipo di materiale e dallo spessore dello strato. Più grande è lo spessore dello strato isolante, maggiore è l’isolamento dell’involucro. L’isolamento così fatto funziona sia per il periodo invernale, impedendo all’calore di uscire, che per il periodo estivo, impedendo al calore di entrare nell’edificio.
L’isolamento delle superfici trasparenti (infissi) è più difficile da ottenere. Essi infatti sono spesso causa di grandi dispersioni termiche ma non si possono eliminare dall’involucro perché sono una prerogativa fondamentale per gli edifici, in particolare per quelli residenziali. Per minimizzare al massimo le dispersioni e riuscire ad avere abitazioni a risparmio energetico bisogna intervenire separatamente sul telaio dell’infisso e sulla parte vetrata. I telai a taglio termico, indipendentemente dal tipo di materiale, sono quelli che garantiscono il maggior risparmio energetico. La parte vetrata ha un ruolo molto importante nella fase di soleggiamento diretto. Il Sole risulta benefico durante il periodo invernale quando il suo calore si aggiunge a quello del riscaldamento, mentre in estate deve essere evitato con adeguate schermature posizionate, se possibile, all’esterno. Invece l’isolamento per minimizzare le dispersioni di calore si può ottenere usando i doppi o tripli vetri con camera d’aria, ancora meglio se con gas a basso emissivo.
Gli impianti della casa a basso consumo energetico
Gli impianti di climatizzazione hanno un ruolo importantissimo negli edifici ed in particolare nelle case. Il risparmio energetico e l'efficienza sono le caratteristiche che valorizzano un impianto di climatizzazione. La climatizzazione può essere soltanto invernale oppure sia per l’estate che per l’inverno. In entrambi i casi, l’impianto deve essere di classe energetica A, ad alto rendimento e deve essere sottoposto regolarmente a revisioni e interventi di manutenzione.
ISOLAMENTO ACUSTICO
Cos'è un rumore?
Da un po’ di anni a questa parte, il rumore è diventato una delle prime fonti di inquinamento: l’uomo, che non ha la capacità fisiologica di isolarsi dal rumore come si isola dalla luce chiudendo gli occhi, ha sentito il bisogno di proteggersi dai suoni. I primi mezzi che permettono di poter gestire meglio il rumore all’interno degli edifici sono legati alle seguenti regole:
- realizzazione della costruzione
- caratteristiche acustiche della costruzione e dei materiali che lo compongono
Un rumore rappresenta un insieme di vibrazioni sonore che corrispondono a delle variazioni della pressione dell’aria udibili da parte dell’uomo.
L’acustica
L’acustica è un settore della scienza che ha come scopo lo studio dei problemi fisici, fisiologici e psicologici connessi all’emissione, alla propagazione, alla ricezione dei suoni e dei rumori.
L’isolamento acustico
L’isolamento acustico è l’insieme delle misure prese per ridurre la trasmissione di energia a partire dalle fonti che la producono fino ai luoghi che devono essere protetti.
I livelli di rumore
Il livello sonoro, espresso in Decibel (dB) indica l’intensità di un rumore o di un suono in rapporto ad una scala di riferimento. Da 10 a 120 dB, la pressione acustica corrisponde a fonti di rumore di natura differente e genera percezioni che vanno dalla calma (10 dB) alla soglia del dolore (120 dB). Questa valutazione o misura del rumore permette, a partire da un suono identificato, di definire un obiettivo per un livello sonoro che si desidera ottenere.
Per essere percepibile, ogni miglioramento acustico deve essere superiore a 1 dB minimo. Se vi sono rumori emessi simultaneamente della stessa intensità o di intensità sonore differenti, i livelli di rumore si sommano.
In particolare, due rumori di eguale intensità produrranno un rumore superiore di 3 dB (esempio, 60 dB + 60 dB = 63 dB) e due rumori di intensità differente produrranno un rumore di valore uguale al valore più forte (60 dB + 80 dB = 80 dB).
Acustica architettonica
1 Rumori aerei esterni
(traffico stradale, ferroviario e aereo).
2 Rumori aerei interni
(conversazione, canali hi-fi, televisori…).
3 Rumori d’urto sul pavimento
(caduta di oggetti, calpestio, trascinamento di sedie)
4 Rumori di attrezzature
(ascensore, rubinetteria, ventilazione meccanica, ...).
La scelta dei buoni materiali
La isolante minerale è un materiale a struttura porosa il cui ruolo essenziale è quello di assorbire l’energia trasmessa dal rumore e rappresenta il miglior materiale per l’isolamento acustico e la correzione degli ambienti sonori posti all’interno dei locali.
La scelta dei buoni sistemi
L’isolamento acustico, in particolare con riferimento ai rumori aerei tra alloggi, locali divisi o sovrapposti, può essere realizzato secondo due tecniche differenti:
- il sistema “massa” per cui l’isolamento acustico è essenzialmente funzione della massa superficiale della parete;
- il sistema “massa-molla-massa” dove l’isolamento acustico dipende dai tre seguenti parametri:
- massa superficiale e natura delle pareti,
- spessore e natura della molla,
- spessore e natura dell’ammortizzatore.
La chiave del sistema "Massa - Molla - Massa": la frequenza di risonanza
L’associazione della parete e della sua massa superficiale, lo spessore della lama d’aria tra i due parametri, la natura e lo spessore della isolante minerale determinano la formazione di una frequenza di risonanza.
La prestazione acustica della costruzione è funzione della posizione di questa frequenza di risonanza. Essa deve, per una buona efficacia di sistema, essere inferiore all’ottava 125 Hz.
A partire da questa ottava, più essa è bassa, migliore è la prestazione.
I rumori d'urto: i pavimenti
I rumori d’urto sui pavimenti possono essere causati da:
- percussione (caduta di oggetti, calpestio, ...),
- vibrazioni (macchinari),
- attrito (trascinamento di mobili).
A causa della continuità rigida delle strutture, la trasmissione dei rumori d’urto raggiunge, al contrario dei rumori aerei, parti dell’edificio molto lontane dalla sorgente del rumore stesso. Per isolarsi acusticamente dai rumori d’urto, la soluzione più efficace in termini di risultati ed efficiente in termini economici, consiste nell’utilizzo del cosiddetto “pavimento galleggiante” il cui scopo è quello di ottenere una pavimentazione priva di collegamenti rigidi con le altre strutture. Questa totale desolidarizzazione è ottenuta interponendo un idoneo materiale elastico tra la pavimentazione, i muri laterali e il solaio portante. Di grande importanza risulta la qualità di realizzazione del pavimento galleggiante poiché anche piccoli collegamenti rigidi riducono sensibilmente le prestazioni di isolamento acustico del sistema.
La scelta dei buoni materiali
La isolante minerale svolge quattro funzioni acustiche che dipendono dalla destinazione dell’opera. Contrariamente a quanto si possa pensare, non sono le lane minerali più dense quelle che offrono le prestazioni migliori.
Funzione di ammortizzatore
L’isolante minerale gioca questa funzione quando, per la sua presenza all’interno dei sistemi massa-molla-massa, essa diminuisce l’ampiezza di un movimento ondulatorio e riduce l’intensità della trasmissione sonora.
Il guadagno nell’isolamento è indipendente dalla massa volumica della lana minerale.
Funzione di molla
La isolante minerale svolge questa funzione quando riduce l’energia sonora grazie alle proprie proprietà di elasticità.
Il guadagno nell’isolamento è, quindi, funzione dell’elasticità della molla.
Funzione di attenuatore
La isolante minerale svolge questa funzione quando essa riduce la trasmissione sonora, utilizzando le sue proprietà intrinseche d’indebolimento acustico.
In presenza di un certo spessore e a parità di isolamento acustico, la lana di roccia deve avere una densità tre volte superiore a quella della isolante minerale.
Ruolo di dissipatore
La isolante minerale gioca questa funzione quando, riducendo i tempi di riverbero, grazie alle proprie qualità di assorbimento, essa diminuisce il livello sonoro. In presenza di un certo spessore e di prestazioni uguali, la lana di roccia deve avere una densità tre volte superiore a quella della isolante minerale.
COME SI COSTRUISCE UNA CASA ANTISISMICA
La costruzione di una casa a prova di terremoto è regolata da una serie di leggi che sono state promulgate a partire dagli anni '70. I provvedimenti più recenti in ordine di tempo sono l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274del 20 marzo 2003 e il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2008, che introduce l'obbligo di un'accurata verifica della staticità di alcune tipologie degli edifici esistenti definiti "strategici", come scuole, ospedali, chiese, musei e ponti. In particolare, il DM in questione definisce i principi per progettare, realizzare e collaudare edifici antisismici.
Riassumiamone i punti essenziali.
COSTRUZIONI NUOVE
Valutazione del rischio sismico. Preliminare a qualsiasi progetto di costruzione di nuovi edifici è la valutazione del rischio sismico della zona da edificare. Bisogna quindi valutare l’effetto della risposta sismica locale in base all'analisi del sottosuolo e delle caratteristiche topografiche. In pratica verificare come un dato luogo reagisce, dal punto di vista geo-morfologico, all'azione di un terremoto. La classificazione delle zone a rischio sismico va da 1 (grado più alto) a 4. La progettazione antisismica è obbligatoria, per l'edilizia pubblica, nelle zone 1, 2 e 3.
L'elenco delle zone a rischio, comune per comune.
Caratteristiche. Gli edifici di nuova costruzione, per essere antisismici, devono possedere i requisiti di sicurezza "nei confronti di stati limite ultimi", ossia capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali. La struttura deve essere progettata in modo tale che il degrado nel corso della sua vita nominale, purché si adotti la normale manutenzione ordinaria, non pregiudichi le sue prestazioni in termini di resistenza, stabilità e funzionalità. La protezione contro il degrado si ottiene attraverso un’opportuna scelta dei dettagli, dei materiali (vedi di seguito) e delle dimensioni strutturali.
Materiali. Un edificio antisismico può essere realizzato in calcestruzzo armato normale o precompresso (quest'ultimo più resistente perché sottoposto a preventivi sforzi di tensione e pressurazione), ossia cemento con barre di acciaio (armatura) annegate al suo interno ed opportunamente sagomate ed interconnesse fra di loro. Le barre possono essere di acciaio al carbonio, o inossidabile o con rivestimento speciale e devono avere un diametro minimo di 5 mm. A seconda del rischio sismico della zona dove sorgerà l'edificio la classe di resistenza del cemento potrà essere più o meno alta (il minimo è Classe 8/10, il massimo è 90/105).
La legge stabilisce quanto devono essere "armati" pilastri e travi, ossia quanto acciaio ci deve essere in proporzione al cemento. La malta o il conglomerato di riempimento dei vani o degli alloggi delle armature deve avvolgerle completamente. Materiali per la saldatura, bulloni e chiodi devono essere conformi alle normative europee (norme UNI EN ISO) e recare la marcatura CE.
Un altro materiale preso in considerazione dalla legge per la costruzione di case antisismiche è il legno, che ha caratteristiche di grande flessibilità, assemblato con adesivi o giunti meccanici.
Secondo la legge, anche una casa in muratura può essere antisismica, a patto che si adottino i giusti criteri progettuali.
Criteri di costruzione. Affinché un edificio non crolli sotto i colpi di un'onda sismica, il rapporto fra trave e pilastro deve essere perfettamente equilibrato. In fase di costruzione la messa in posa di pilastri e travi deve avvenire contemporaneamente, onde evitare la creazione di "giunto" che mina la stabilità dell'edificio. La legge stabilisce la dimensione minima dei pilastri, definita con termine tecnico "snellezza". Lo spessore minimo di un muro portante, invece, è 15 cm, il massimo è 50 cm. Quanto alla progettazione, la pianta degli edifici deve essere il più possibile regolare e simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze. L'altezza deve essere limitata in relazione alla classificazione sismica del territorio: ad esempio, le case che ricadono in zona 1, quella a massimo rischio sismico, non devono superare i due piani di altezza se in muratura ordinaria, tre piani se in muratura armata (nel caso di progettazione semplificata). Il segreto di una costruzione a prova di terremoto sta nella capacità di prevedere le spinte orizzontali tipiche delle onde sismiche. Per questo ad esempio bisogna evitare i cosiddetti tetti spingenti, ossia quelli fatti con travi che spingono verso le pareti. Si devono costruire, invece, tetti a capriata, come quelli delle chiese gotiche, ossia con una struttura portante, dalla forma reticolare triangolare, con la funzione di sorreggere la copertura del tetto a spiovente.
Verifiche. L'edificio antisismico deve poter resistere a torsioni, flessioni, deformazioni, tagli, vibrazioni, fessurazioni, tensioni, corrosioni. Bisogna inoltre verificare l'aderenza delle barre d'acciaio con il calcestruzzo. Anche le costruzioni in legno vanno sottoposte a prove di robustezza e staticità, in particolare per verificare la resistenza a trazioni, flessioni e compressioni sia parallele che perpendicolari alla fibratura del legno stesso. In fase di progettazione la resistenza a tutte queste sollecitazioni si ricava applicando le norme di calcolo illustrate dettagliatamente nella legge. Il collaudo statico, invece, deve essere effettuato in corso d’opera.
Costi. La costruzione di un edificio antisismico costa mediamente il 30% in più rispetto a uno normale.
COSTRUZIONI ESISTENTI
Tutti gli interventi di adeguamento e miglioramento per aumentare la sicurezza degli edifici devono seguire le stesse regole di progettazione, uso dei materiali e verifica della staticità delle case di nuova costruzione.